È dei giorni scorsi la nota con cui la diocesi di Milano comunicava che il trentaduenne don Alberto Ravagnani...
Le conseguenze dei dazi
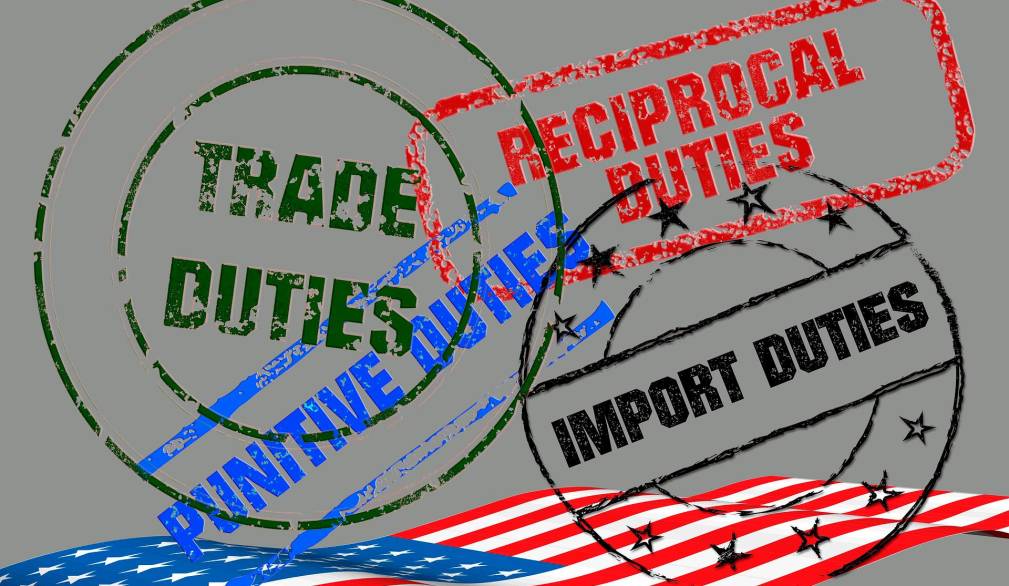
Gli economisti spesso non sono d’accordo tra di loro. Ciò non significa che non vi siano argomenti sui quali, invece, c’è una sostanziale unanimità. é questo il caso dei vantaggi derivanti dal commercio internazionale e, per converso, della dannosità, salvo pochissimi e specifici casi, delle restrizioni, come ad esempio i dazi.
Da oltre due secoli gli economisti conoscono la “teoria dei costi comparati”, elaborata da David Ricardo nel 1817, secondo la quale il commercio internazionale avvantaggia sempre tutti i Paesi che vi partecipano senza danneggiarne alcuno. Conseguentemente, la teoria economica ha messo in risalto come la liberalizzazione commerciale internazionale non solo espande la varietà dei beni disponibili e riduce i costi, grazie alla specializzazione dei Paesi, ma porta anche a una maggiore efficienza complessiva dovuta alla "riallocazione" delle risorse. Oggi, in pratica, non esiste più qualcosa che assomiglia al libero scambio riportato nei testi di economia, perché il mercato internazionale è regolamentato dall’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), ma il sostanziale giudizio positivo sul commercio internazionale è rimasto immutato.
Da più lungo tempo gli economisti conoscono, invece, l’esistenza di una frequentissima forma di restrizione del libero mercato come i dazi e le loro conseguenze.
Tributi analoghi ai moderni dazi si trovano fin dall’antichità e nell’alto Medioevo, ma è soprattutto a partire dal XII secolo che, specie nelle maggiori città mercantili, si sviluppa un vero e proprio sistema doganale. Il mercantilismo prevalente nell’età moderna provocò un crescente intervento dei governi in materia doganale e commerciale, ma già all’inizio del XVIII secolo il risorgere dell’interessamento per l’agricoltura portò a reagire contro la politica annonaria e a invocare la soppressione delle dogane interne e dei divieti di esportazione. Il trionfo del liberismo fu tuttavia di breve durata, perché sia la necessità di favorire lo sviluppo delle industrie nazionali sia quella di difendere l’agricoltura contro la concorrenza dei paesi d’oltremare indussero ben presto molti Stati a istituire nuovi dazi e a elevare le tariffe doganali con conseguenti dazi di rappresaglia anche da parte di altri Stati.
La Prima guerra mondiale accentuò ovunque il protezionismo, sotto la pressione delle svalutazioni monetarie, delle necessità di bilancio e di quelle della produzione interna. La Seconda guerra mondiale intervenne a inasprire ancor più la situazione e a soffocare i pochi indizi di distensione che andavano riaffiorando, ma già prima che fosse finita, gli Usa presero l’iniziativa per una progressiva liberalizzazione degli scambi.
Dopo la Seconda guerra mondiale l’Italia, seguendo l’orientamento generale, si è volta verso una politica di libertà degli scambi. Più in particolare, l’adesione alla Comunità economica europea (Cee) ha comportato, da un lato, l’abolizione graduale dei dazi nei confronti degli altri Paesi membri della Comunità e, dall’altro, l’adozione di una tariffa doganale unica di tutti i Paesi della Cee verso i Paesi terzi. Nell’ambito dell’unione doganale la determinazione dei dazi esterni degli Stati membri, che costituiscono un unico territorio doganale, rientra tra le competenze esclusive degli organi comunitari. L’esigenza di assicurare l’uniformità del regime degli scambi con i Paesi terzi ha inoltre indotto la Commissione della Comunità Europea a elaborare un codice doganale comunitario.
Il dazio un’imposta calcolata sul valore e/o (più raramente) sulla quantità di una merce che varca, in entrata (importazione) o in uscita (esportazione), la frontiera doganale (che può essere diversa da quella politica) del Paese. Il dazio può essere specifico, nel senso che colpisce soltanto determinate merci e/o Paesi terzi, oppure generalizzato (o indifferenziato) e quindi esteso a tutte le merci e a tutti i Paesi.
L’effetto più immediato è quello di aumentare il prezzo del bene colpito e quindi, di conseguenza, una diminuzione della sua domanda. Tale diminuzione sarà più o meno ampia in funzione dell’intensità della variazione della quantità domandata rispetto al prezzo (elasticità della domanda). Per i beni di prima necessità, caratterizzati da una domanda poco elastica o addirittura rigida, la variazione sarà minima o perfino nulla, mentre per i beni voluttuari, tipicamente con elevata elasticità, la variazione sarà ampia.
Per proseguire l’analisi delle conseguenze di un dazio bisogna distinguere il caso in cui esso sia posto sulle importazioni da quello (relativamente più raro) in cui colpisca le esportazioni.
I dazi sulle importazioni hanno l’obiettivo primario di colpire i produttori esteri dei beni tassati, la cui domanda dovrebbe diminuire, in base all’elasticità, e quindi provocare una diminuzione dei profitti, della produzione e dell’occupazione. In definitiva, una diminuzione del Pil dei Paesi a cui appartengono i produttori colpiti. Ciò potrebbe provocare, da parte di questi Paesi, una reazione di rappresaglia, cioè una imposizione a loro volta di dazi sui beni provenienti dal Paese che per primo ha scatenato quella che potrebbe diventare una vera propria guerra commerciale. E come insegna la storia, non solo le guerre commerciali sono a somma negativa, nel senso che alla fine tutti risultano sconfitti, ma anche che, talvolta, sono purtroppo foriere di successive guerre militari.
All’interno del Paese che ha posto i dazi sulle importazioni l’aumento del prezzo di queste ultime avrà un effetto inflattivo a tutto danno dei consumatori, mentre gli eventuali produttori degli stessi beni importati vedranno aumentare i loro profitti e, protetti dai dazi, non dovranno temere la concorrenza estera e quindi non avranno alcun incentivo a migliorare la loro efficienza e la loro produttività. Viene così a crearsi un perverso effetto distorsivo nella distribuzione del reddito e nella struttura produttiva del Paese. L’unico effetto positivo sarà un aumento delle entrate fiscali e, quindi, un miglioramento del saldo del bilancio pubblico. Questo spiega perché talvolta i dazi abbiano avuto un obiettivo primario di natura fiscale.
È questo il caso dei dazi sulle esportazioni che per alcuni Paesi in via di sviluppo, ricchi di materie prime, ma scarsamente attrezzati dal punto di vista burocratico e amministrativo, sono un facile mezzo per garantire un consistente gettito tributario. Questa volta a subire le conseguenze inflattive saranno i consumatori dei Paesi destinatari delle esportazioni, mentre è probabile che la domanda non diminuisca sensibilmente trattandosi di beni scarsamente elastici come le materie prime.
Rimane ora da accennare ai limitatissimi casi in cui è ragionevole imporre dei dazi alle importazioni. Ne ricorderemo tre: quando è necessario proteggere temporaneamente dalla concorrenza estera un’industria nascente; quando i Paesi terzi producono a costi bassissimi, perché violano norme giuridiche e di civile comportamento in materia di lavoro e/o di protezione ambientale; quando, infine, ci si trova di fronte a una qualche forma di dumping, cioè di concorrenza sleale, perché i prodotti vengono venduti a un prezzo che non rispecchia in modo accurato il costo di produzione.
Donald Trump ha una concezione mercantilista che ci riporta al XVI secolo quando si riteneva che la potenza di uno Stato dipendesse dal suo surplus commerciale, cioè da un valore delle esportazioni superiore a quello delle importazioni. Ciò spiega perché, ai suoi occhi, gli Stati Uniti non saranno una grande potenza finché avranno un costante deficit commerciale e perché qualunque Paese che abbia un avanzo commerciale con l’America sia un potenziale nemico. Di qui il ricorso ai dazi per "make America great again (fare nuovamente grande l’America) e per punire Cina, Messico, Canada e Europa che si permettono l’ardire di esportare negli Usa più di quanto importano. È un’idea sbagliata, ma finché qualcuno dei premi Nobel in economia di sua conoscenza non glielo spiegherà e non lo convincerà a cambiare idea, non ci resta che prenderne atto e reagire di conseguenza.
Prima di avventurarci a descrivere in modo sommario le probabili conseguenze, in Europa e soprattutto in Italia, dei dazi di Trump è opportuno rilevare che ciò che il Presidente americano ha finora detto e fatto (in realtà più detto, spesso in modo volubile e contraddittorio, che fatto), un risultato certo lo hanno provocato: quello di aver creato un diffuso clima di attesa e di incertezza che rischia di paralizzare i mercati. Non conoscendo cosa riserverà loro il futuro immediato imprenditori e consumatori assumono un atteggiamento di prudente attesa e rimangono immobili in attesa degli eventi. Un clima che se dovesse perdurare potrebbe avere gravi e rilevanti conseguenze. é dunque augurabile che se ne esca, comunque, al più presto.
In risposta ai dazi imposti da Donald Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio, l’Unione Europea ne ha annunciati altri come ritorsione e poiché Unione Europea e Stati Uniti vantano la più stretta e importante relazione bilaterale commerciale e di investimento al mondo, rischiano di esserci gravi ripercussioni sulle catene di approvvigionamento, sui prezzi e i posti di lavoro.
Le conseguenze di queste misure possono essere particolarmente evidenti in alcuni settori dell’economia in cui si concentra l’interscambio commerciale. Nel 2024, quasi la metà (49,5%) delle esportazioni dell’Ue verso gli Stati Uniti si è concentrata in cinque categorie: al primo posto i prodotti farmaceutici e medicinali (22,5%), seguiti da veicoli stradali (9,6%), macchinari industriali generici (6,4%), apparecchiature elettriche (6,0%) e macchinari specializzati (5,0%).
Dagli Stati Uniti i Paesi europei importano soprattutto cinque tipi di prodotti, che nel 2024 hanno rappresentato il 50,4% del totale delle importazioni da questo Paese: petrolio e derivati (16,1%), prodotti farmaceutici (13,8%), macchinari per la generazione di energia (9,2%), gas naturale (5,8%) e altri mezzi di trasporto (5,5%).
L’annuncio dell’introduzione di tariffe doganali del 25% sui prodotti europei potrebbe avere gravi ripercussioni per l’Italia. Nel 2024 le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti hanno raggiunto i 65 miliardi di euro, con un surplus commerciale di 39 miliardi, un dato che pone l’Italia tra i Paesi più esposti a tali restrizioni. Come calcolato da Prometeia, i dazi americani potrebbero costare alle aziende italiane tra i 4 e i 7 miliardi di euro. Il colpo sarà particolarmente duro per quattro settori che esportano molto negli Stati Uniti: le bevande italiane, che vendono il 39% della loro produzione sul mercato Usa, le automobili (30,7%), altri mezzi di trasporto come yacht e moto (34%) e i medicinali (30,7%), ma anche il vino italiano (soprattutto il prosecco), le borse, le scarpe e gli altri beni di lusso made in Italy dovranno affrontare prezzi molto più alti per i consumatori americani. Lo stesso vale per i macchinari industriali che da sempre rappresentano un punto di forza dell'export italiano.
Il quadro è ancora più complesso per le piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura del sistema produttivo italiano: molte di queste non hanno la capacità finanziaria di assorbire i costi aggiuntivi dei dazi o di trasferire rapidamente la produzione in territorio americano, come invece potrebbero fare le grandi multinazionali. Oltretutto questa situazione arriva in un momento già difficile, perché le aziende stanno affrontando maggiori spese a causa delle nuove regole ambientali introdotte negli ultimi anni con il piano per la transizione ecologica.
Per rispondere a questa doppia pressione, Confindustria suggerisce di cercare nuovi sbocchi commerciali al di fuori degli Stati Uniti e di accelerare i negoziati commerciali con altri Paesi asiatici e africani.
Un'ulteriore preoccupazione deriva dal pericolo che i prodotti cinesi, respinti dal mercato americano, possano arrivare in Europa a prezzi molto bassi, creando un'ulteriore difficoltà per le aziende europee già in affanno.
L’Italia deve resistere alla tentazione di sperare di potersi ritagliare una solitaria posizione privilegiata, magari contando sui rapporti di amicizia personali, sia perché la comprovata volubilità dell’interlocutore di oltre Atlantico non fornisce sufficienti garanzie di affidabilità, sia perché, come ricorda l’economista Tito Boeri sulla rivista Eco 2/2025, “le frontiere dell’Italia nei confronti degli Stati Uniti sono le frontiere dell’Unione europea: il nostro Paese da solo non ha alcuna speranza di poter incidere su scelte che vengono compiute Oltreoceano. Non ha né gli strumenti (le politiche commerciali vengono decise a livello comunitario) né la forza negoziale per farlo. E poi, ammesso e non concesso che ci venga riservato un trattamento di favore rispetto ai danni inferti agli altri Paesi dell’Unione, l’Italia ne subirebbe comunque i contraccolpi in virtù della fortissima integrazione economica che ha con gli altri Paesi dell’Unione, a partire dalla Germania”. Pertanto, anziché inseguire ingenue quanto furbesche chimere, il nostro Paese farebbe meglio a unirsi a Francia e Germania per guidare, da protagonista, una maggiore coesione europea e una ferma risposta unitaria.
L'autore:
Lucio Malfi, nato e residente a Venezia, si è laureato a pieni voti in Economia e Commercio a Ca’ Foscari nel 1958. Dal 1960 al 1985 ha diretto l’Istituto regionale di ricerche economico-sociali del Veneto (Irsev). Nello stesso periodo è stato professore incaricato di Contabilità nazionale a Ca’ Foscari e di Istituzioni di statistica economica a Padova. Dal 1986 al 2003 è stato professore di ruolo di Politica economica presso la facoltà di Statistica dell’Università di Padova, insegnamento che ha tenuto fino al 2010, anche dopo il collocamento in quiescenza. Presso la stessa facoltà ha tenuto anche gli insegnamenti di Macroeconomia, di Economia applicata e di Economia e politica del lavoro. È autore di quasi un centinaio di pubblicazioni scientifiche.











